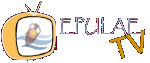Organo Ufficiale dell'Accademia Internazionale Epulae
Direttore Responsabile
Angelo Concas
Saperi e sapori
Dulcis in fundo
di Giuseppe Oddo
04/03/2007

Un motto tardolatino recita: Dulcem rem fabas facit esuries tibi crudas. La fame ti trasforma le fave crude in una cosa dolce. E’ vero. Non c’è cosa più o meno commestibile che non acquisti sapore di squisitezza quando si ha fame. Non si sono forse nutriti di licheni i popoli scandinavi, in certi periodi della loro storia? A Roma, nell’autunno del 1943 «c’erano donne che frugavano tra le immondizie dei cassonetti per trovare foglie e torsoli da cucinare» testimonia Miriam Mafai. «Si masticavano a lungo, le castagne secche, le “mosciarelle”, o le carrube. La fame aveva un sapore dolciastro». Ma le cose dolci, o cosi ruci, in Sicilia sono sempre state sinonimo di dolciumi. E, a memoria d’uomo, mai siciliano ha scambiato le fave crude per cosi ruci. Un ruolo vicario dei dolci è stato caso mai assolto dalle fave abbrustolite, meglio note come favi caliati. I contadini ne facevano scorpacciate nelle serate d’inverno attorno al focolare, mentre qualche anziano della famiglia dotato di buona favella li intratteneva raccontando qualche cuntu di tesori incantati, re, fate, regine, principi e principesse o magari faceva rivivere le gesta dei Paladini di Francia, Orlando, Rinaldo, Guerin Meschino, Rizzieri, la bella Angelica… La calia (fave e ceci abbrustoliti) faceva inoltre la sua immancabile comparsa assieme allo scacciu (mandorle e nocciole tostate) e ai confetti nelle feste di nozze o di battesimo delle famiglie povere. E continua tutt’ora ad accompagnarsi alla simenza (semi di zucca essiccati al sole) nelle feste patronali, senza mai confondersi con i prodotti del cubbaitaru (torrone, petrafennula, gelato di campagna, ecc.) che pure fanno bella mostra sulle bancarelle ovunque si festeggi un Santo. Naturalmente, specialmente nei tempi andati, i popolani non facevano mai passare la festa senza rifarsi il palato con un pur minuscolo pezzo di cubbaita che il venditore gli consegnava sempre rigorasamente avvolto nella carta oleata. Astenersene sarebbe stato come non aver rispetto per il Santo e per le sacrosante aspettative di guadagno del cubbaitaru. Molti però potevano portare a casa solo poche briciole dell’appetitoso dolce, quando non dovevano accontentarsi del proverbiale scrusciu di carta senza cubbaita. La cubbaita, che il Vocabolario Siciliano-Italiano di Antonino Traina (1868) presenta come «confettura o torrone o mandorle e mele cotto», in Sicilia si consuma da parecchi secoli. A riprova di quanto ne sono stati ghiotti in ogni epoca i Siciliani, basti ricordare che nel Cinquecento nella Contea di Modica fu istituito un apposito balzello per tassare i guadagni dei cubbaitari. Ma già allora si conoscevano moltissimi tipi di dolci e tanti altri sono stati inventati nel frattempo. Il loro numero nessuno lo conosce: i ricercatori non si sono mai avventurati nella compilazione dell’elenco completo. Giuseppe Coria, che pure ha pubblicato ben 250 ricette di dolci, ammette che il suo «è solo un tentativo, una brevissima introduzione, ai tanti volumi che di essi si potrebbero scrivere». Ed aggiunge: «Di alcuni mi è stato impossibile trovare la esatta ricetta: così delle caniate di Regalbuto; dei cassateddi di ficu di Mazara del Vallo; dei sampiroti di San Pier Niceto, delle tabelle (biscotti rotondi di 15 cm. di diametro) di Santa Maria di Licodia; dei viscotta di meli che si preparano nella Sicilia occidentale per la festa di S. Michele (29 settembre), e raffiguranti l’Arcangelo; i pantofuli di pistacchiu dell’agrigentino e nisseno; i masticutté di Assoro nell’ennese. E questi solo per citarne qualcuno». Marinella Fiume Giannetto si sofferma sui contenuti culturali della pasticceria sacra come di quella profana. «La grande varietà morfologica dei dolci siciliani - sostiene opportunamente -, la ricchezza figurativa, la pregnanza simbolica si spiega riportandosi a una tradizione lontanissima che affonda nella preistoria le sue origini e che risulta da un intreccio sincretico di tradizione pagana e rivoluzione cristiana, di patrimonio magico-rituale di una società agro-pastorale e di sconvolgimenti socio-politici di vasta portata storica». Movendo da queste considerazioni l’autrice coglie anche il rapporto che lega quella che, citando Uccello, lei chiama «la raffinata e fantasiosa dolceria siciliana, patrimonio dell’aristocrazia» alla parallela produzione popolare o vastasa, «intenta a supplire con la fantasia alla congenita scarsità delle risorse e che non differisce dalla prima che per l’arricchimento di preparazioni-base comuni a tutte le classi». Ora, le distinzioni e gli accostamenti sono necessari in ogni discorso analitico; finiscono però spesso per scivolare nello schematismo, come la stessa Fiume Giannetto riconosce con grande onestà intellettuale. A noi convince poco, per esempio, la riproposizione della classica dicotomia “dolceria sacra – dolceria profana”. Siamo invece del parere che la stragrande maggioranza dei dolci, se non proprio la totalità, almeno di quelli siciliani, affondi le radici nella sfera del sacro: è sicuramente così per la cassata siciliana che un tempo simboleggiava la Pasqua (chiamata perciò Pasqua di li cassati) e che oggi si prepara in ogni periodo dell’anno ed è così anche per le sfinci che prima si consumavano solo in occasione della festa di San Giuseppe. Non sfuggono alla regola nemmeno il cannolo e la pignolata, già dolci tipici del Carnevale. Il periodo carnevalizio è infatti tutto interno al calendario liturgico; e i suoi precedenti più antichi vanno forse ricercati nei Saturnali di classica memoria, feste solenni romane in onore del Dio Saturno. La dolceria profana, nella misura in cui esiste, quando non è di derivazione sacra, è un suo sottoprodotto. E’ il caso dei pipatelli, consumati la domenica sera dalla borghesia palermitana del passato. Erano infatti, per dirla con Nicola Volpes, «biscotti ottenuti impastando rimasugli di dolci di ogni genere». Tradivano pure un’origine sacra le nievuli (che un tempo si vendevano nelle strade della Capitale) dato che erano «cialde simili alle ostie abbrustolite e leggermente zuccherate». Si obietterà che certi dolci tuttora prodotti e un tempo tipici di alcuni riti di passaggio (nozze e battesimo), come i tetù e le taralle sembrano sfuggire al nostro assunto. A ben riflettere, però, a parte il fatto che essi - come del resto i confetti - caratterizzavano momenti decisivi della vita, solitamente scanditi in tutte le culture da pratiche magico-religiose, i tetù erano (e continuano ad essere) specialità della festa dei morti; le taralle una squisitezza d’origine ebraica nella cui preparazione entra il succo di cedro, frutto sacro che gli Ebrei solevano tenere in mano entrando nel Tempio. I gelati e le caramelle sono probabilmente i soli prodotti tipici dell’arte dolciaria profana, anche se non è da escludere che potessero avere qualche rapporto che non conosciamo con la sfera sacra nel momento della loro prima preparazione. Certo è che sono figli della cultura araba, tenuto conto che vengono manipolati entrambi con lo zucchero che, com’è noto, fu importato in Sicilia dagli Arabi. Non c’è dubbio inoltre che, almeno nei centri agricoli, il gelato un tempo si mangiava sotto forma di pezzo duro solo in occasione delle feste del Santo Patrono. Le caramelle, prodotto squisitamente urbano, si vendevano in mezzo alle strade di Palermo, specialmente quelle d’artìa che lo stesso venditore ambulante preparava «utilizzando come forme certe striscioline di carta arrotolata». Ebbene, saranno state pure prodotti della dolceria profana, parto della fantasia creativa di poveri diavoli che si arrampicavano sugli specchi per mettere insieme il pranzo e la cena… ma di fatto il caramillaru sentiva il bisogno di farsi il segno della Croce appena vendeva la prima caramella della giornata. Origine sacra avevano pure i dolci nati all’epoca degli dei falsi e bugiardi. L’esempio più noto è quello delle famose focacce a base di farina, sesamo e miele (mylloi), raffiguranti le pudende femminili, che i Siciliani offrivano in grandi canestri a Demetra e Persefone in occasione delle Tesmoforie, accompagnando l’offerta con gesti osceni e linguaggio licenzioso. Curiosamente questo dolce, almeno nella forma, ma con ingredienti diversi (pasta di mandorla, crema d’uovo e marmellata d’albicocche), è stato riprodotto per secoli dalle suore della Badia del Cancelliere di Palermo con il nome di feddi di cancilleri. I mustacei dell’antica Roma, la cui ricetta (a base di farina, cacio, mosto, anice, cimino e scorza d’alloro) ci è stata tramandata da Catone nel De Agricoltura, furono creati per solennizzare le nozze di Saturno. Il loro nome ancora oggi riecheggia nel sicilianissimo mustazzolu, caratteristico delle feste di Natale, nonché «uno dei dolci tipici della nostra isola che può assumersi a simbolo della lunga durata nelle sue strutture di base, pur nelle modificazioni e innovazioni sia delle tecniche di manipolazione, che delle valenze rituali e, in generale, di temperie culturali». Non rimane più traccia, invece, della placenta, descritta da Catone e avente come ingredienti essenziali farina, cacio e miele «fragrante di timo ibleo». Ma un dolce siciliano evocativo delle antiche focacce dolci si prepara ancora: la fuàzza di purtuisa. E il miele siciliano continua a dare fragranza e sapore a molti dolci natalizi, a cominciare dalla favuzza, che nel nome e nella forma allude al fallo. Rimandano pure al sesso, sia pure indirettamente, altri dolci a base di farina e miele destinati ai bambini. Non per caso alle bambine si regala (o meglio si regalava) la pupa e ai maschietti lu cavaddruzzu (cavallino). Moltissimi sono i dolci devozionali con il miele. In proposito vale la pena di riportare le parole di Sebastiano Burgaretta, autore di un pregevole saggio su api e miele degli Iblei: «A Natale, con l’inizio dell’anno liturgico si usa tutt’ora preparare il torrone di mandorla, la più pregiata della quale è quella di Avola, che appunto si presta benissimo alla confezione di confetti e di torrone a base di miele. Leonardo Sciascia ha scritto: “Con tanta abbondanza di mandorle, ad Avola prospera la produzione dei confetti e del torrone. Il quale è prodotto in due tipi: bianco e caramellato, più docile al coltello e ai denti il primo, più duro e quasi vetrino il secondo. La differenza a quanto pare consiste nella lavorazione più e negli ingredienti meno. Forse nel primo ha parte più importante il miele, che ad Avola se ne ha di ottimo…” A base di miele si prepara, ad Avola e dintorni, anche la ghiugghiulena, un impasto di sesamo e miele. Biscotti di farina e miele si praparano in tutto il Siracusano per la ricorrenza di Natale. Sono quelli che ad Avola hanno forma o della lettera S o di spirale e vengono chiamati mustazzola, a Noto pasti ri meli, a Sortino piretti, perché hanno forma di piccole pere con all’interno frammenti di mandorla abbrustolita. A Noto e nel Modicano si confezionano rami ri meli, dolci dalla forma di ramoscelli fatti con farina di miele. Questi dolci, che negli ingredienti ricordano quelli che nel Palermitano si preparano in occasione della festa dei Santi Cosma e Damiano, vengono dati ai bambini per la strina, cioè come strenna di Capodanno […] I mustazzola ri meli sembrano diretti discendenti dei dolci di cui parla Teocrito nell’idillio XV, meglio conosciuto come - Le Siracusane -. Riporto i versi di Teocrito nella traduzione siciliana che recentemente ha fatto il poeta netino Gaetano Passerello: ‘Nta li maiddi tanti fimmineddi ‘mpastanu ccu farina rosi e ciuri, ccu ogghiu e meli e tanti pampineddi e tutti a gloria di stu gran Signuri. (Nelle madie tante connette / impastano con farina rose e fiori, / con olio e miele e tante erbette aromatiche, / e tutto a gloria di questo gran Signore). Sempre a Natale a Modica si preparano i nucàtuli, con miele, farina, fichi secchi e noci tritate avvolti in una sottile sfoglia di pasta. Altro dolce natalizio a base di miele è la pignuccata, fatta con farina e uova. Tipici del Modicano sono i dolci natalizi a base di miele e che vanno sotto il nome di citrata o aranciata […] Nel Ragusano si usa preparare le palmette, dolci a base di farina mescolata con mandorla tostata e triturata e miele. Si fanno dei romboidi un po’ schiacciati che vengono cotti al forno». C’è, in tutti i dolci natalizi a base di miele, un’unità significante di un comune sistema di comunicazione non verbale. Nel caso dell’aranciata e della citrata di Modica (dette pure entrambe petrafennula) ciò che più colpisce, oltre alla proverbiale durezza, è la forma cilindrica, simbolo fallico per antonomasia. Ma persino certi dolci fitomorfi come le palmette di Ragusa, evocativi della pianta sotto cui si rifugiò Maria Vergine durante la fuga in Egitto nascondono un preciso significato sessuale. Sì, perché la palma è simbolo di fecondità. Non a caso nella Puglia dei nostri giorni un dolce a forma di palma è donato dal fidanzato alla fidanzata, la quale calcola la portata dell’amore del promesso sposo basandosi sull’altezza dell’albero-dolce ricevuto. Ed è forse privo di significato il fatto che nei matrimoni le amiche offrivano, alla fine del corteo nuziale, abbondanti cucchiate di miele alla zita? Certamente no, considerato che nelle colonie siculo-albanesi era la suocera che «stava aspettando all’uscio la nuora per porgerle un cucchiaio di miele». Oltre a quelli di miele, in Sicilia si preparavano altri dolci natalizi che in origine erano pani con frutta secca (fichi, mandorle, uva passa, noci, ecc.). I nomi variano da comune a comune (cucciddata, gucciddata, vucciddata, peddizzati, luni, ecc.). In alcuni paesi questi dolci vengono messi in mostra, accanto al Presepio, in apposite sagre del periodo natalizio. Ma tutte le feste del calendario sono caratterizzata da dolci tipici, in Sicilia. D’altra parte la festa, come ha scritto Fatima Giallombardo, «scandisce le fasi del calendario: essa è cioè legata all’organizzazione sociale del tempo. E’ il mezzo con cui le popolazioni affidano quasi per intero la loro sopravvivenza all’ordinato svolgersi dei cicli naturali, fanno regolarmente ricorso per risolvere gli stati d’incertezza vitale ed esistenziale. Il momento rituale ripropone sul piano mitico le proprietà di abbondanza e pienezza di vita che, attraverso un processo di definizione formale, conferiscono a chi vi partecipa stati di certezza e di sicurezza. Ambiente, tempo, società nei rituali festivi risultano dunque correlati. E’ perciò possibile, in riferimento alla festa, parlare di scansione sociale del tempo non solo perché essa ripropone a livello mitico-rituale la sicurezza vitale del gruppo, ma anche perché questo, attraverso la socializzazione rituale, assume consapevolezza di essere nel tempo, ritrovando gli stessi giorni, il ripetersi degli stessi cicli e degli stessi fenomeni di morte e rinascita della natura». Se questo è il significato più profondo della festa, non può sorprendere il fatto che a creare l’atmosfera del lungo e complesso iter celebrativo della Settimana Santa nell’Isola siano altri dolci tipici che contribuiscono a presentare in una dimensione metastorica non solo la morte e la resurrezione di Gesù Cristo ma anche l’eterna trepidazione contadina per la sorte delle sementi affidate alla terra, da cui in definitiva dipende la sopravvivenza della specie umana. «La settimana santa - usiamo le parole di Antonino Buttitta - assicura la rigenerazione periodica dell’anno attraverso la rappresentazione simbolica delle fasi conclusive del mito del dio salvatore. La pasqua è la morte e la rinascita di Dio, ma anche la rinascita della natura, la nostra rinascita a nuova vita liberati da tutti i peccati». I dolci pasquali, divenuti ormai in molti comuni capolavori di pasticceria tipica, erano un tempo sostanzialmente pani. Le innovazioni non riescono del resto a nascondere le differenti stratificazioni culturali e gli originari significati. «Così, al simbolismo originario della Pasqua come rito di rinascita della natura si riconnettono i dolci che contengono l’uovo, elemento centrale delle rappresentazioni cosmogoniche; alla sua matrice semitica sono da riportare invece quelli che raffigurano l’agnello, mentre all’iconografia cristiana sembrano rinviare i dolci a forma di colomba». A parte le uova al cioccolato e le colombe pasquali prodotte industrialmente, tipici dolci pasquali sono da noi la cassata siciliana (ormai conosciuta in tutto il mondo), le cassatelle con la ricotta, fritte o al forno, i biscotti con l’uovo che nel Palermitano si chiamano pupi cull’ova e i picureddi, «pecorelle di pasta reale, la cui posa è divenuta ormai un classico: sdraiate sopra un prato verde disseminato di confetti multicolori, con una banderuola rossa, simile a quella che nell’iconografia sacra è in mano a San Giovanni, infilzata sul dorso». Ciascuna di queste specialità pasquali richiederebbe più di una considerazione aggiuntiva che mal si concilia con l’economia di questa riflessione. Ci limitiamo perciò a spendere poche parole per i cosiddetti pupi cull’ova. Nel presentarli al vasto pubblico della Mostra Etnografica del 1891-92, Giuseppe Pitré volle precisare: «Diconsi pupi coll’ova certi pani e certe paste dolci di proporzioni diverse, e con forma di bambola, di pupattola, di prete, di mostro, o d’altro, sopra od entro le quali forme sono delle uova sode». Sull’argomento Giovanni Ruffino ha pubblicato un saggio di geografia linguistica ed etnografica con un bellissimo corredo iconografico che presenta ben dodici aree di produzione, «ciascuna delle quali si caratterizza per un tipo lessicale prevalente» e «una dozzina ancora di aree isolate, prive di consistenza territoriale». I nomi sono molti. Si passa dal campanaru al cannatuni, al cannateddu, al cicìu, al cicilìu, al pupu cull’ovu, al cannileri, al panareddu, all’aceddu, ai varati, alla caddura cull’ova, alla palummedda. Da altre fonti sappiamo che a Bisacquino si preparano dolci con le uova a forma di seno femminile detti minneddi. Interessantissimi sono i riti (rispolverati dal saggio di Ruffino) che un tempo accompagnavano il consumo di questi dolci. A San Biagio Platani il fidanzato (zitu) donava alla zita un cannileri con dieci uova. Nei quartieri marinari di Sciacca il dolce destinato alla fidanzata conteneva ben ventuno uova. Nelle famiglie contadine della stessa città «la zita usciva di casa a mezzogiorno del sabato santo per recarsi a casa del futuro sposo, al quale faceva dono di un cannileri con nove uova, mentre ne riservava uno con quattro al suocero e con due alla suocera». Comunque chiamati, in tutta la Sicilia i dolci con le uova si mangiavano solo dopo la Resurrezione. A Sant’Agata Militello, prima di addentare i pasturi, il membro più anziano della famiglia bruciava un po’ d’incenso e benediceva i familiari. A Favignana il campanaru si mangiava dopo aver baciato la terra. A Centuripe, ma anche altrove, il dolce equivalente si consumava in chiesa dopo la caduta della tela e la scampanata a gloria. A Montelepre c’era la stessa usanza e per di più i fedeli ripetevano la formula: A gloria sunàu; caunateddu si spizzàu; e si fici a mmostra a mmostra, caunateddu senza ossa. Il campionario della pasticceria devota siciliana è troppo vasto per proporlo nella sua interezza alla fruizione dei lettori. Sarebbe però un peccato non accennare ai principali pezzi di devozione che un tempo contribuivano più di adesso ad infondere sicurezza e a rinsaldare i vincoli comunitari. Penso al majali che si preparava a gloria di Sant’Antonio Abate, protettore del bestiame; alle olivette di S. Agata e alle minni di Virgini con cui tutt’ora si rende omaggio alla gloriosa protettrice di Catania, cui è affidata la protezione delle mammelle e quindi dell’alimentazione dei neonati; alle sfinci, alle torte e ai tanti altri dolci che ancora oggi compaiono nelle Tavolate di San Giuseppe; alla stessa pasta cu la muddica, con zucchero e cannella che viene distribuita ai devoti dell’amato Patriarca nelle Cene del 19 marzo a Salemi; alla varva di San Giuseppe con miele che compare lo stesso giorno nelle mense devote dell’Ennese; alla varva di San Binirittu con graniglie di pistacchio e canditi, tipica della Valle del Belice; ai dolci antropomorfi di sussameli, raffiguranti i Santi Cosma e Damiano che esercitano il loro protettorato sui marinai di Palermo. Un discorso a parte merita la chiavi di S. Petru che si mangia il 29 giugno a Palermo, nel Partinicese, a Sciacca, a Modica e in altri comuni. Ma forse è il caso di farlo con le parole di Pitrè: «Verso la metà di giugno si cominciano a vendere per Palermo, sparse e ammonticchiate sopra tavole e canestre, chiavi di pasta melata (di meli) di pasta e mandorle e abbrustolite (sussamela), di torroncino, di cannella e di altro dolciume […] Vi sono chiavi di mezzo metro, anche d’un metro, che si portano sopra tavolette. La gridata per lo spaccio delle chiavi è tradizionalmente questa: Chi l’haiu bedda grossa la chiavi…haiu la chiavi grossa!». La simbologia fallica del dolce di S. Pietro traspare dalle stesse parole del venditore che ne reclamizzava la grossezza e soprattutto dal fatto che il fidanzato la regalava (e continua a regalarla) alla zita come «dovere di galateo amoroso». Pani e dolci votivi si confezionavano anche in occasione della festa di Santa Febronia a Palagonia: «uno a forma di mano, con farina, uova e zucchero; e un altro di pasta di pane, che simboleggia un gallo». A Palermo il festino di Santa Rosalia ai tempi di Pitré era allietato dai muscardini; adesso non più. Ma gli stessi dolcetti odoranti di cannella, si fanno ancora a Mazara del Vallo il giorno della festa del Corpus Domini e nella Valle del Belice in occasione della commemorazione dei defunti. In compenso nella capitale dell’Isola il festino è un vero trionfo di bancarelle colorate, artisticamente dipinte come i carretti siciliani, traboccanti dei soliti dolci delle feste patronali ma anche calia e simenza, mennuli agghiazzati, cioè «confetti di mandorla in camicia di glassa». E le famiglie consumano a gloria della Santuzza il primo gelo di mellone dell’anno, di cui faranno più grosse abbuffate a ferragosto. Insomma, come tutti i salmi finiscono in gloria, così tutte le feste siciliane si concludono con grandi vassoi di cosi ruci. E i dolci non mancano nemmeno il giorno in cui si ricordano i morti. Anzi, in qualche comune, come Paternò, le vedove li mangiano accanto alla tomba della buonanima, dove passano l’intera giornata del 2 novembre, dall’alba al tramonto. Ovunque nell’Isola quel giorno i bambini ricevono dolciumi dai parenti defunti: bambole e cavallucci di zucchero colorato (detti anche pupi di cena o pupa a-ccena), ossa di morti, ossia «dolci di pasta forte, aromatizzata al garofano, a forma di tibie e di teschi», nucatuli, dolcini di riposto, tetù, taralline, miliddi, pasti di meli d’ogni forma e colore, frutti di martorana. Questi traggono il nome delle suore di Santa Maria della Martorana di Palermo cui si deve, a quanto pare, l’invenzione. Si tramanda anzi che le religiose ebbero modo di preparare questi dolci anche in onore del papa che visitò Palermo alla vigilia della festa dei morti. Gli fecero trovare un improbabile albero stracolmo di mele, pere, susine… di marzapane (detto pure pasta reale perché fatto con lo zucchero, allora prodotto nelle aziende ricadenti nel demanio regio). E il pontefice decise di regalare quei frutti di martorana ai bambini poveri in occasione della festa dei morti. Per devozione a S. Lucia, protettrice di Siracusa, il 13 dicembre molti siciliani si astengono dal consumo di pane e di pasta. All’origine di tale usanza c’è una leggenda: durante una carestia arrivò, finalmente, una nave carica di grano, proprio il giorno della festa della Santa. I suoi devoti decisero perciò di ringraziare la Patrona mangiando una minestra di grano chiamata cuccìa. Con l’aggiunta di zucchero, crema di latte o di ricotta, zucca candita, scorza di limone e pezzetti di cioccolato, l’umile pietanza è divenuta un dolce prelibato: la cuccìa duci, appunto. A Palermo si mangiano pure panelli duci; frittelle di farina di ceci con zucchero e cannella. Poiché S. Lucia è la protettrice della vista, in alcuni comuni dell’ Isola, si sogliono preparare in suo onore anche dolci e pani votivi raffiguranti gli occhi o sottili sfoglie come i cucciteddi di Modica che non si mangiano né si conservano come talismani sacri, se prima non vengono fatti adagiare un momento sulle palpebre chiuse. A Collesano, nella chiesa di S. Lucia, il 13 dicembre, alle cinque del mattino, viene celebrata una messa, a conclusione della quale si offrono ai fedeli «biscotti a forma di occhi realizzati dalle suore o da coloro che hanno ricevuto una grazia». Prima di raggiungere i traguardi attuali, la tradizione dolciaria siciliana è stata per secoli monopolio quasi esclusivo di religiosi e monache di casa, cioè professe laiche che non mancavano mai nelle famiglie della buona società. Queste pie donne col cordone, costrette dalle circostanze della vita a consumare l’esistenza tra il forno e la chiesa, in qualche realtà della Sicilia orientale erano chiamate ducceri, tanto erano brave a confezionare dolciumi. Ma i migliori dolci sono stati tradizionalmente quelli preparati nei conventi: li cosi ruci di li batii, come li chiamavano i nostri avi. Si ricordano in proposito (oltre ai citati frutti di martorana e feddi di cancilleri), i minni di Virgini e i bocconetti delle suore di S. Caterina di Palermo, i triunfi di gula del vicino monastero di Montevergine, le crispelle dolci dei Benedettini di Catania, la pignulata dell’Ordine della Carità di Messina, il cuscus di pistacchio del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento, i viscotta di la zza monica e i fusiddi di li monici di Sciacca, li cosi ruci di la batìa di Paternò, i facciuni di S. Chiara di Noto. Le più fantasiose pasticciere si sono dimostrate, forse, le oscure suore di Modica che inventarono la ‘mpanatigghia, capolavoro dolciario nato per sopperire alle carenze nutrizionali di predicatori che si alternavano nei pulpiti dell’Isola durante la Quaresima. Per eludere il rigido divieto di mangiare carne, le astute religiose «ricorsero all’espediente di tritare finemente il filetto di manzo camuffandolo sotto una coltre spessa di cioccolato e riponendo il tutto all’interno di una pasta sottilissima e friabile a base di sugna, ripiegata a guisa di mezzaluna dal bordo finemente intagliato con un piccolo cratere eruttivo al centro». E crearono la ‘mpanatigghia, il cui nome richiama quello delle empanadillas importate dagli Spagnoli dal Nuovo Mondo. «Decisamente incredulo – assicura Anna Caschetto – è l’atteggiamento di chi assaggia per la prima volta questi sorprendenti “dolci da viaggio”, capaci di conservarsi per più settimane». Isola santa, la nostra. Isola carogna! E’ proprio il caso di ripeterlo con Gesualdo Bufalino. Terra dove spesso, troppo spesso, le apparenze ingannano.
Giuseppe Oddo